|



Mappa del XVII secolo

Croce
di Lorena

Redentore

Lapidi funerarie
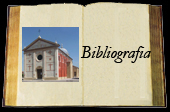
|
|
Chiesa di Santa Maria Annunziata
L’attribuzione del fonte battesimale è sicuramente successiva al 1152, perché
Moniego non appare nell’elenco delle Pievi contenuto in una bolla papale di
Eugenio III.
Una cappella è menzionata nelle Rationes Decimarum Italiae del 1297. Nel
1334 in un registro delle decime del vescovo di Treviso è citata come pieve
plebs.
La dipendenza fino al 1815 della parrocchia di Santa Maria Annunziata di Moniego
dal Patriarcato di Aquileia è uno dei fatti più significativi e al tempo stesso
sorprendente.
Sicuramente pochi, guardando la chiesa di Moniego, si accorgono della
particolare croce che svetta in cima al frontone della facciata. E’ la croce
patriarcale, simbolo visibile del legame che ha unito, fino al 1815, la
parrocchia di Santa Maria Annunziata ad Aquileia. Forse la parrocchia era una “pertinenza” dell’Abbazia
benedettina di Sesto al Reghena (PN). Secondo
L. Bovo e G. Zorzetto nel libro L’Antica Pieve di Moniego
ad
avvalorare l'ipotesi vi è un documento di donazione al
monastero del 762 con il quale i due fratelli longobardi Erfone e Marco lasciano
ai monaci fra gli altri beni anche le corti e le case in “molenego o
mulinego” che,
dal contesto dell'atto sembrano essere identificabili nella zona di Moniego.
Dell'originario edificio, sicuramente ampliato nel 1300 e consacrato nel 1321 rimangono
solamente alcune delle decorazioni della cornice esterna ad archetti, nella
vecchia sacrestia una lapide con l'iscrizione a caratteri gotici del 1365
e il tabernacolo murale ora custodia degli oli sacri del XIV secolo.
Tra il 1486 ed il 1497 la chiesa è stata ampliata, la
facciata è stata rifatta e il tetto rinnovato. Il disegno ed i lavori della nuova chiesa furono
seguiti dall’architetto veneziano Giovanni Candi (1440-1506), mentre era parroco
il frate francescano Grecolco da Scutari, come risulta dall’iscrizione nel
fregio della facciata. Lo stesso parroco, come è ricordato in una lapide
interna, nel 1512 volle l’edificazione del
campanile.
La facciata è ornata
da quattro grandi lesene con capitelli dorici, cornicione e timpano con
modiglioni e nel recente restauro del 2008 sono riapparse diverse decorazioni
del cinquecento. All'interno del timpano rimangono tracce di affresco raffigurante
l'Annunciazione. Decorazioni trecentesche sono presenti sui muri esterni nord e
sud e sul muro esterno della sacrestia vecchia ora cappella Grimani
sono presenti delle scritte sacre e un cartiglio testimonianza che la
costruzione di quella parte della chiesa è avvenuta nel 1522 ad opera di Martino
Murario. Sul muro sud è presente uno stemma della famiglia Grimani e all’esterno,
sulla parete nord, sono murate le lapidi funerarie del notaio Lorenzo Sorgato da
Noale (1471) e di Giovanni Battista Tremonti (1875). La statua del redentore posta
sopra la cupola è del '400.
Entrando nell’edificio sacro, come ci testimonia lo storico Fapanni, fino al
secolo scorso, si potevano ammirare, sulle pareti laterali e sul soffitto,
diversi affreschi riguardanti scene evangeliche, opere non pregevoli
artisticamente, ma di sicuro effetto ed insegnamento per i parrocchiani di
Moniego. Oggi, dopo la ristrutturazione dell’edificio nel 1926, le pareti sono
completamente spoglie, il soffitto e le sue pitture sono sparite e le alte
finestre sono diventate lunghi e stretti finestroni. Dodici grosse travi (12
apostoli) sostengono all’interno il tetto della navata abbellito da artistiche e
colorate listelle lignee, in numero di 150 per ogni fascia tra trave e trave,
sicuramente riferibili alle 150 Ave Maria dei 15 Misteri del Rosario.
La chiesa ha cinque altari. Avanzando verso il presbiterio balza subito agli
occhi la maestosità, la bellezza e l’eleganza dell’altare Maggiore, in stile
classico-rinascimentale. La pala dell’altare l'Annunciazione, del 1584, è opera di
un artista
sconosciuto di scuola veneta.
Ai lati dell’altare vi sono due tele recenti
(1919) opera dell'artista Noè Bordignon che sostituiscono degli affreschi
seicenteschi gravemente danneggiati. Quella di destra raffigura l’Ultima Cena,
quella di sinistra la Natività. Anche i quattro medaglioni degli
Evangelisti, che possiamo vedere entro triangoli tra la cupola e il presbiterio
sono opera dello stesso pittore ed eseguiti sempre nel 1919. Un coro ligneo di
squisita fattura, databile ai primi anni del 1500, fiancheggia da ambo i lati
l’altare maggiore. Nella parete destra del presbiterio è murata un tabernacolo
della prima metà del XIV secolo che oggi serve quale custodia degli oli santi
A metà delle navate vi sono due altari entrambi sullo stile di Alessandro
Vittoria, scultore e medaglista (1525-1608) allievo del Sansovino. L'altare
della navata di sinistra prende il nome del Crocifisso da un artistico
crocifisso ligneo del settecento appeso sulla mensa. L'altare della navata di destra è
dedicato alla Madonna. Una tela sopra l’altare ricorda che prima si venerava la
Vergine di Loreto, ma poi il posto della Santa Casa, sostenuta dagli angeli, è
stato preso da una statua della Madonna con Bambino del della fine del XV
inizio XVI secolo, per tradizione detta "Del Pan", invocata
così perché si riteneva che la Vergine tenesse in mano un pane.
Ai lati dell' arco centrale del presbiterio vi sono a destra l'altare di Sant'Urbano e a
sinistra quello di San Valentino. La pala dell'altare di Sant'Urbano del XVII secolo
è di
autore ignoto e raffigura il Santo Pontefice e Martire Urbano con ai lati sant'Antonio Abate e
san Bernardino. La tela dell' altare di San Valentino è un’opera del
pittore Gino Borsato (1960) e raffigura san Valentino, santo molto popolare a Moniego.
Dal presbiterio si accede alla sacrestia vecchia (1522) attraverso una bella
porta in legno scolpita a motivi floreali e vitigni che ricordano l’ Eucarestia. L’interno di quella che oggi viene chiamata Cappella Grimani, da un affresco
raffigurante il Risorto con a lato un doge supplicante con lo stemma dei Grimani,
dentro lunette sono raffigurati anche i quattro evangelisti (XVI secolo) e le
effigie di alcuni sacerdoti (XVII secolo). Su una parte della sacrestia è conservata la lapide in volgare del 1365.
Sulla parete interna della facciata è
appesa una lapide romana della fine del I secolo a.C. rinvenuta nel 1990 durante
lo scavo per le fondamenta della nuova cantoria a sostegno del nuovo organo.
Sempre nell'antifacciata è presente un'iscrizione del 1603. Il battistero è
del XVII secolo.
Sull'elegante cupola svetta la statua del Redentore.
Davanti alla chiesa si innalza per oltre 50 metri un maestoso campanile
eretto nel 1512. |