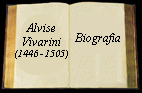Assunzione di Maria Vergine
(1502-1504)
La
pala, commissionata dalla confraternita dei Battuti, era collocata
nell'altare dell'Assunta dove aveva sostituito un dipinto del 1454 del
quale non si hanno notizie. La potente e ricca confraternita poteva
permettersi continue sostituzioni dei dipinti seguendo le mode del
momento culturale e nel 1513 è stata a sua volta sostituita con un
dipinto di ignoto autore raffigurante Gesù Cristo in croce tra la
Vergine, san Giovanni, san Sebastiano e san Cristoforo del quale si
è persa memoria.
Il
dipinto è un'opera di splendente cromaticità tutta veneta. Maria, ormai
irraggiungibile, immersa già nella luce dell'eternità, attira occhi e
cuori degli apostoli. In alto a sinistra, su un'improbabile collina, si
vede un castello.
La pala appartiene all'ultimo periodo della pittura di
Alvise Vivarini (1442 – 1505) e risente fortemente dell'influenza
artistica di Cima da Conegliano al quale per secoli il dipinto è stato
attribuito da storici e critici d'arte e bisogna arrivare al 1871 con
Giovan Battista Cavalcaselle per incontrare i primi dubbi
sull'attribuzione al Cima. Nel 1929 Giuseppe Fiocco nei volti delle
persone riconosce schemi ripresi da Antonello da Messina e da Lorenzo
Lotto e nel 1959 Luigi Coletti attribuisce il dipinto a Domenico
Capriolo. Per accostare l'opera al linguaggio pittorico dei Vivarini
bisogna attendere il 1979 quando Mauro Lucco confrontando l'opera
noalese con altri dipinti avanza le prime ipotesi di attribuzione ai
Vivarini.
Spetta a Saverio Simi de Burgis la pubblicazione in Arte Veneta
52 (1998)
del ritrovamento di un documento del 1502
nell’Archivio Comunale di Noale che ha permesso di attribuire la pala
dell’Assunta ad Alvise Vivarini. Trattasi precisamente della
documentazione di un processo datato 1° settembre 1502 che vede come
parti in causa, da una parte il pievano Ettore della Bastia e dall’altra
Pietro Sartor e Andrea Violato, in qualità di Massari della Scuola di
Santa Maria dei Battuti, da cui il pievano esige il pagamento di 36
ducati da lui anticipati per saldare il pagamento della pala del
Vivarini. Fortunatamente per noi, all’istanza di rimborso sono allegati:
la ricevuta del 27 novembre 1504 ed il contratto stipulato con lo stesso
Alvise Vivarini nel 1502.
L’opera commissionata era una pala “a figure
at oio, et prima nel campo de mezo la asension de la madona cum i
duodeci apostoli, nel campo dextro san Hieronymo en heremo et nel zancho
san Sebastian, neli duo quadri de sopra la Anunziata, et di sopra ditti
quadri la pietá.
La pala era stata descritta nel '700
anche dallo storico locale mons. G.B. Rossi: “Forse a questa Scuola (Confraternita
dei Battuti) apparteneva la Pala tutta di legno di finissimo lavoro
dorata, divisa in tre quadri; in quello di mezzo si rimira la Beata
Vergine Assunta con di sotto gli Apostoli ed all’intorno alcuni Angeli,
e nei laterali San Girolamo e San Sebastiano: al di sopra poi altri
piccioli due quadri sopra i due maggiori laterali, si vedono l’Angelo in
uno e la Beata Vergine Annunciata nell’altro. Lavoro di eccellente
pennello imitatore e forse superiore a Vettor Carpaccio. Si conserva in
chiesa, sopra il banco de’ Massari”.
In questo dipinto l’artista era ritornato forse per
esigenze di contratto alla tipologia della pala d’altare frazionata in
scomparti che aveva abbandonato già nel 1480, come si può vedere nella
Madonna in trono e santi (a Venezia nelle Gallerie
dell’Accademia), dove l’abbandono della rigida composizione lascia
spazio ad un’apertura paesaggistica sullo sfondo.
L’Assunta che oggi ammiriamo é dunque la parte centrale e
l’unica rimasta di un complesso polittico, originariamente collocato
sull’altare della Scuola dei Battuti, committenti dell’opera e purtroppo
delle altre opere costituenti l’altare si sono perse le tracce.
Ma anche dopo che il dipinto é stato attribuito con
certezza al Vivarini rimane in sospeso una nuova ipotesi. Sin dal 1982
lo Streer confrontando l'opera noalese con la Sacra Conversazione
di Amiens e la Madonna con il Bambino e quattro santi di Berlino
notò una marcata differenza stilistica tra la parte inferiore del quadro
e la parte superiore dove troneggia una ieratica Madonna che ascende al
cielo in una mandorla di luce, sorretta da statici angioletti che fa
supporre l’intervento di un altro artista. Potrebbe trattarsi del
giovanissimo Lorenzo Lotto che in quei anni frequentava la bottega di
Alvise Vivarini, la cui Apparizione della Vergine ai santi
antonio Abate e Ludovico da Tolosa di Asolo (1505) presenta diverse
affinità con l’opera noalese: la Vergine é raffigurata anche qui a
figura intera, circondata da una specie di mandorla che la contiene, di
un’analoga tonalità arancione.